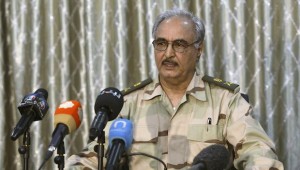Ho
paura. Ho deciso di vantarmene. E mi assumo il compito di propagarla.
Mi rendo conto. Non si comincia così un libro contro la morte che arriva
al galoppo impugnando la scimitarra. Non è molto nobile. Si deve
cominciare con un grido di guerra. Eppure, lo confesso: ho deciso di
buttare la fifa oltre l'ostacolo.
Ho paura adesso, e anche per dopo. Per quando queste mie pagine saranno in giro per l'Italia.
E qualche frase rimbalzerà su Internet. S'incazzeranno, oh se
si incazzeranno. Perché ho intenzione di scrivere la verità su quel che
ha, in testa e nella pancia, non solo la gentaglia con le bandiere nere
e le mani sul collo di poveri prigionieri vestiti di arancione, ma
anche il musulmano dal dolce sorriso ospite di trasmissioni tivù,
dispiaciuto per i morti e nemico, come no, del terrorismo. Prevedo
l'accusa di provocatore irresponsabile. Papa Francesco dirà che mi
merito un pugno. Portatemi pure in tribunale, sempre meglio
dell'obitorio, a cui siamo destinati in tanti se la paura non ci desterà
dal sonno dei pirla.
Dirò qui la verità sugli islamici e il loro
Allah con il Profeta Maometto appresso. Non la Verità con la V
maiuscola, per carità. La verità con la v minuscola ritengo sia la più
importante acquisizione della mia vita. Ho imparato ad attingerla con il
cucchiaio dell'osservazione e dell'esperienza, senza presumere divine
rivelazioni. Non c'è bisogno di essere arabisti per capire, anche senza
assaporarne i suoni aspirati, che il Corano ha in sé una potenza
distruttiva assoluta verso chiunque manifesti un sussulto di libertà e
dica no al dominio di un libro che si è fatto Dio, così come si sono
fatti suoi boia coloro che lo impugnano.
Ho paura. Lo ridico. Si osservi la realtà.
Un
Coulibaly e due Kouachi si sono manifestati a Parigi. Quanti Coulibaly a
Milano, quanti Coulibaly a Londra? Mi faccio questa domanda, e mentre
la scrivo con la Olivetti 32, un Coulibaly qualsiasi spara contro un
vignettista e gli avventori in un bar di Copenaghen, e altri danno
l'assalto alla sinagoga della capitale danese. Intanto lo Stato islamico
avanza in Libia, con giganti vestiti di nero che sgozzano 21 cristiani
copti minuscoli, a un tiro di missile Scud, magari nucleare.
Non è
vero che queste immagini, da loro diffuse con orgoglio, vogliano
impaurirci. Hanno un altro scopo: quello di inorgoglire i loro
correligionari di casa nostra, e di spingere ragazzi annoiati a
convertirsi all'onnipotenza. Poi, certo, desiderano indurci alla resa.
Come quelle povere madri ebree in fila verso la camera a gas con i
bambini per mano. Dobbiamo avere più paura di quella che abbiamo. Una
paura così grande da trasformarsi nel coraggio di uccidere per non
morire. Una paura intelligente, organizzata. Senza il cappello in mano
per domandare l'elemosina della vita (quelli non si commuovono,
figuriamoci), ma con l'elmetto in testa e un pugnale tra le mani. Ci
ammazzeranno lo stesso, forse, ma forse vinciamo.
Non riesco, non
riuscirò mai a capire chi accetta di scavarsi la fossa, e lo fa sotto il
tiro di un fucile, sapendo che chi impugna la carabina tra un minuto
ripagherà la sua fatica sparandogli. Nell'isola di Utøya, in Norvegia,
il 22 luglio 2011, un uomo solo uccise 69 ragazzi (dopo aver ammazzato 8
persone nel centro di Oslo). Sull'isola, quel giorno, c'erano seicento
giovanotti in gamba, motivati politicamente, pieni di energia. La loro
paura li disarmò, li spinse a nascondersi. Se gli andavano addosso
insieme, tremando come foglie di sicuro, ma stringendosi l'uno all'altro
per la fifa, il killer ne avrebbe stecchiti quattro o cinque, poi gli
altri 595 avrebbero sbranato quell'Anders Breivik, che adesso,
condannato a 21 anni, è triste per non averne ammazzati abbastanza.
Ho
scritto questa verità elementare, e mi hanno attaccato come se avessi
offeso le vittime. E dire che il mio articolo nasceva
dall'immedesimazione con quei disgraziati. Vale adesso per noi. Dobbiamo
organizzare la paura, consapevoli che il nemico di Charlie Hebdo non si
fa intenerire dai tremori.
Ho paura. Eppure ho paura di non avere abbastanza paura per riuscire a trasmettervela.
Siamo
un po' tutti così, noi dell'Occidente che non sta capendo un accidente.
Tiepidi non dico nel coraggio, ma persino nel timore, inclini a
minimizzare, a ritenerci salvi nel nostro orto per non si sa quale magia
o corazza invisibile.
Domina una sorta di ottimismo idiota. È
sintetizzabile con il motto: «Male non fare, paura non avere». Lo so che
lo ripeteva la mamma a Enzo Biagi. Vale in un mondo perduto. È una
regola utile quando incontri un orso in Trentino. Con i musulmani non
funziona. Non è vero che se stiamo buoni, se non reagiamo, se non
sfioriamo neanche con un fiore il turbante di Maometto, i suoi adepti ci
lasceranno stare. Basti guardare come nelle loro terre gli islamici
scannano i cristiani, che pure abitavano lì prima di loro. Maometto lo
fece con gli ebrei di Medina, ne sgozzò personalmente settecento (ma c'è
chi dice novecento). Secondo questa teoria, tutto nasce dalla nostra
cattiveria. E prima da quella degli americani. E prima ancora dei
crociati. Per cui se consentiamo loro, qui da noi, di costruirsi le
moschee, di intabarrare le loro donne nei veli, oltre che di percuoterle
e segregarle, considerandoli affari loro, nulla di male ci capiterà. È
l'idea dell'Occidente e in particolare dell'Italia come brodo
multiculturale. Tu non fai una cosa a me, io non la faccio a te.
Tolleranza.
Balle suicide. Chi ragiona così non sa nulla
dell'islam. Lo misura sulla base del sorriso che gli dedica il pizzaiolo
egiziano. Eppure l'ho visto il sorriso largo un metro della colf
somala, che mi aveva sempre servito gentilmente le polpette, alla
notizia delle Torri Gemelle. Non che il pizzaiolo e la colf siano più
cattivi di te e di me. Là il Corano , una volta che ne inghiotti gli
insegnamenti, è una sorgente di morte (per gli altri).
Non faccio
nessun appello al coraggio. Il coraggio se n'è andato dall'Italia il 15
settembre 2006, quando le campane di Santa Maria del Fiore hanno
salutato Oriana Fallaci, e l'abbiamo seppellita. Abbiamo rovesciato
palate di terra sul suo grido «Troia brucia, Troia brucia». Per questo
mi affido all'arma estrema e molto albertosordiana della vigliaccheria
per sopravvivere, sperando che le generazioni future – se mai oseranno
nascere – riprendano una certa fierezza di esistere, un orgoglio da noi
sepolto nella noia.
***
Mi rendo conto di apparire rozzo e
irresponsabile, populista e ignorante agli occhi della sinistra al
caviale e del cretinismo parrocchiale, quello che della lezione di
Ratzinger a Ratisbona non ha capito nulla. Si potrebbe chiamare
«complesso di Lepanto». Coincide con il rimorso spalmato sulla coscienza
collettiva dell'Occidente dal marxismo terzomondista e dal suo gemello
cattocomunista secondo cui è ben giusto che paghiamo il prezzo delle
crociate di Roberto il Guiscardo. E soprattutto è stato criminale
fermare l'avanzata turca con la guerra, il cui momento decisivo è
rappresentato appunto dalla battaglia navale di Lepanto, quando vascelli
veneziani, genovesi, spagnoli e pontifici annientarono il 7 ottobre
1571 la flotta ottomana del sultano protesa alla conquista di Roma. Alì
Pascià ci lasciò la pelle. E la sua maledizione perseguita ancora tante
anime belle, convinte che la faccenda si sarebbe dovuta appianare con il
dialogo. Da qui una debolezza mentale che ci tiriamo dietro. Ce la
saremmo voluta noi, che paghiamo la colpa dei nostri antenati, questa
incazzatura della Mezzaluna.
L'invasione islamica, del resto, dopo
quella data non ha mai smesso di essere desiderata dai musulmani. E il
territorio perduto, rivendicato. La «reconquista» della regina Isabella
che si riprese l'Andalusia lo stesso anno della scoperta dell'America,
1492, esige secondo gli arabi di essere vendicata con la
«re-reconquista». La cacciata dei 300.000 mori dalla Spagna (1609)
esige, secondo gli imam, il risarcimento di una rioccupazione del
territorio. E infatti questa procede, eccome se procede, fino a
trasformarci in Eurabia. Un processo che nelle librerie e nei caffè
parigini e sulle terrazze romane è stato interiorizzato senza
protestare.
Certo, quando questa invasione esagera nei modi,
impedisce la satira e mitraglia Charlie (gli ebrei del negozio kosher
sono meno popolari, e si ricordano meno), per un paio di giorni
esponiamo tutti il cartello dell'indignazione e della solidarietà. Ma
poi ci si riaccomoda a sopportare il procedere dell'invasione. La quale
non si è ancora realizzata pienamente in senso fisico, in compenso da
tempo l'Occidente è sotto il dominio di una cultura propensa ad aprirle
le porte. C'è un sistema di credenze che inzuppa la testa dei governi e
di tutto l' establishment editoriale e finanziario, cedevole verso
l'islam e spietato con chi eccepisce e non intende rinunciare a una
certa spiacevole sensazione di turlupinatura quando gli si parla della
bontà di Allah e dei suoi seguaci più infatuati.
In conclusione,
il tipo dell'intellettuale con gli occhialini, mescolato ai teologi e
agli islamologi, ha licenza esclusiva di occupazione di giornali,
librerie, scuole, università, chiese e tribunali. Il multiculturalismo
tollera solo la cultura multiculturale. Perché, grazie alla magia del
suo nome, ha il pluralismo incorporato, e dunque chi eccepisce si pone
fuori dal consesso democratico. È una specie di partito unico, essendo
già multipartitico nel nome.
Questa pre-invasione, questo
pasturaggio culturale, funziona come una specie di fumisteria di oppio.
Intasa le menti con la leggenda di un islam fiabesco, profumato di
spezie, con i tappeti volanti e il cielo stellato sopra bianchi
minareti, insozzato dalle cattiverie occidentali. I fatti di Charlie
Hebdo hanno smagato la favola? Per un attimo. Poi sono tornati in massa
gli esperti a separare l'accidente del terrorismo dalla sua sostanza
religiosa, quasi che il primo sia un virus occidentale inoculato in un
corpo orientale innocente. Secondo la colta vulgata da salotto
televisivo e da dibattito universitario, questa religione di vergini
incantevoli e fedeli misericordiosi non c'entra nulla con la sua
esibizione terroristica. È vero, ammettono: il grido «Allah u Akbar»
ovvero «Allah è il più grande» è il marchio di fabbrica della violenza
riversata per esempio a New York, Madrid, Londra, Parigi, Bruxelles, ma è
un fenomeno spiegabilissimo senza coinvolgere l'islam e il Corano.
Vittorio Feltri - 14 maggio 2015
fonte: http://www.ilgiornale.it